Le imprese più innovative sono quelle che offrono ai lavoratori più diritti, sicurezza e stabilità, non quelle dai contratti a breve termine e dal licenziamento facile
Del mai così famoso ed abusato concetto di flessibilità esistono diverse definizioni. In particolare, dal punto di vista dell’impresa, possiamo distinguere tre tipologie di flessibilità: flessibilità numerica ovvero la capacità delle imprese di far variare il numero delle persone occupate al loro interno, attraverso il ricorso a contratti di lavoro atipici; flessibilità funzionale che indica l’abilità dell’impresa ad organizzarsi in maniera flessibile senza ricorrere ai licenziamenti, facendo variare il numero dei dipendenti attraverso una forza lavoro capace di ricoprire un ampio raggio di compiti; flessibilità salariale ovvero l’attitudine del sistema delle retribuzioni a rispondere alle condizioni del mercato variando con facilità.
Se risulta ormai chiara l’esistenza di una correlazione negativa tra la crescita della produttività e il ricorso a lavoratori a tempo determinato (flessibilità numerica), è interessante considerare la relazione tra le principali forme di flessibilità introdotte (numerica e salariale) e il grado di innovazione delle imprese. Infatti, anche se l’innovazione (insieme alla spesa in Ricerca e Sviluppo, R&S) rappresenta uno dei fattori principali in grado di avviare meccanismi virtuosi di sviluppo e crescita delle imprese, essa viene scarsamente richiamata quando si discute di lavoro. Se ne occupa però una parte della letteratura economica, da cui riprenderemo alcuni esempi specifici che risultano d’aiuto per valutare anche il caso italiano. Michie and Sheehan (2003), partendo da alcuni dati riguardanti il settore manifatturiero inglese, osservano che “le imprese più innovative sono proprio quelle che hanno deciso di non ricorrere a queste nuove forme di lavoro, frutto della deregolamentazione, ma che hanno invece perseguito una sorta di flessibilità funzionale associata non a contratti temporanei di breve durata, ma al contrario, ad una maggiore sicurezza occupazionale”. In altri termini:“Non vi è alcuna prova della possibilità che la flessibilità introdotta in seguito alla deregolamentazione del mercato conduca ad un’economia più innovativa”. Questa affermazione, nella sua nettezza, stride fortemente con le frequenti argomentazioni che spesso vengono utilizzate per giustificare il ricorso ad una maggiore flessibilità.
Allora, all’interno di un dibattito che badi seriamente al contenuto della discussione, sarebbe necessario specificare il tipo di flessibilità che si vuole rincorrere, a partire però dai risultati già chiaramente osservabili in merito a quella numerica e salariale.
Kleinknecht et al.(2010) conducono un’indagine simile analizzando dati longitudinali riguardanti le imprese dei Paesi Bassi, da cui emerge chiaramente che le possibilità per un’impresa di adottare prodotti nuovi per il mercato, assumendo così una posizione leader rispetto agli altri competitors, sono negativamente influenzate da un elevato ricorso a lavoratori temporanei. Secondo gli autori, questo dato rende esplicita la necessità di favorire ed attivare un processo di accumulazione della conoscenza che può aver luogo, però, solo una volta creati rapporti di lavoro stabili e continuativi, capaci tra l’altro, di trasmettere un senso di fiducia ed appartenenza tra i lavoratori. Lucidi e Kleinknecht (2009) approfondiscono proprio questo aspetto, attraverso un’analisi sull’economia italiana, affermando che uno degli effetti della maggiore flessibilità del lavoro potrebbe essere un forte sottoinvestimento nella formazione dei lavoratori. Infatti, se i rapporti di lavoro sono di breve durata, allora le imprese hanno pochissimi incentivi ad investire nella formazione dei lavoratori, mentre dall’altra parte questi saranno riluttanti all’idea di acquisire delle competenze strettamente legate all’impresa in cui solo momentaneamente risultano occupati se non percepiscono un impegno di lungo termine con i propri datori di lavoro. In un contesto simile, le relazioni e il luogo di lavoro hanno subito profondi cambiamenti che pongono degli interrogativi concreti non solo sul dato “freddo” dell’andamento della produttività, ma ancor di più sulla natura frammentaria, atomizzata e fortemente gerarchica assunta dal rapporto lavoratore-imprenditore.
Infatti è innegabile che un lavoratore, soggetto al “ricatto” di un contratto a termine da rinnovare, non avrà nessun incentivo a muovere delle critiche, seppure in un’ottica costruttiva, ai suoi datori di lavoro in merito per esempio alla gestione delle risorse o all’organizzazione interna. Questa ritrosia al dialogo ed estraneità al confronto influenza e modifica l’ambiente di lavoro nel suo complesso, e lo rende sempre più impersonale e precario, determinando così il venire meno di uno dei punti di vista fondamentali (quello del lavoratore) nonché, cosa ancora più grave, ostacolando ed impedendo l’istaurarsi di un rapporto che sia equilibrato, trasparente e paritario con il proprio datore.
Attraverso dei rapporti caratterizzati da maggiore continuità e collaborazione invece, da una parte si andrebbe a promuovere ed incentivare la volontà dei lavoratori di condividere la propria conoscenza tacita con gli altri colleghi, dall’altra si andrebbe a stimolare l’investimento in programmi educativi e formativi da parte dell’impresa, meno propensa a licenziare un lavoratore su cui ha investito direttamente. In altri studi (Arulampalam et al.,2003; Wallette, 2005) è stata messa in evidenza proprio l’esistenza di una correlazione negativa tra forme di lavoro a tempo determinato e attività di training e formazione offerte dalle imprese stesse. Tali risultati suggeriscono degli interventi in materia di politiche del lavoro completamente differenti da quelli di cui si dibatte in questi mesi in Italia e mostrano le profonde contraddizioni e debolezze di un modello teso a confermare ed incentivare ulteriormente non solo la flessibilità in entrata, ma anche quella in uscita. Se infatti le imprese italiane adottassero un’ottica di lungo termine (piuttosto che inerpicarsi sull’incerto e scivoloso sentiero della minimizzazione dei costi), esse percepirebbero il lavoratore come la principale risorsa su cui investire, essenziale per aumentare la propria competitività e difficilmente sarebbero disposte ad “esodarlo”. E’opportuno allora sottolineare come, nel caso italiano, abbiano pesato e continuino a pesare fortemente la totale mancanza di un sistema di relazioni industriali capace di garantire ai lavoratori diritti, sicurezza e stabilità occupazionale e l’assenza di una progettualità concreta volta a riformare i modelli organizzativi all’interno dell’impresa. Eppure risulta ormai largamente dimostrato che l’organizzazione interna ha un’influenza specifica sulla produttività e più in generale sulla performance dell’impresa. Leoni (2010) ricorda come le componenti più strategiche nell’ambito operativo (ovvero quelle cognitive, relazionali e gestionali) si “formano sul posto di lavoro attraverso una serie di pratiche lavorative quali: l’esercizio di operazioni non routinarie, la job rotation, gli incentivi all’apprendimento, il lavoro in team, la consultazione e il coinvolgimento del lavoratore attraverso un sistema di suggerimenti dal basso, la partecipazione a gruppi di miglioramento e lo sviluppo di una carriera in diagonale (più che verticale).”
L’idea di un’impresa “internamente flessibile”, capace di unire innovazioni organizzative, nuove pratiche del lavoro e un ripensamento delle relazioni gerarchiche e del grado di partecipazione del lavoratore appare un concetto del tutto sconosciuto in Italia.Nel nostro paese negli ultimi decenni si è deciso di ignorare quasi totalmente le potenzialità dell’Hpwo (High performance work organization), ovvero di un’organizzazione del lavoro capace di accrescere il capitale organizzativo e favorire in maniera duratura la competitività (e l’aumento dei salari). Infatti, se guardiamo al comportamento delle imprese italiane, vediamo che i loro investimenti in R&S e formazione, il tasso di innovazione congiunta, la quota di ICT e quella di export high tech sono tra i valori più bassi d’Europa. Si potrebbe obiettare che le imprese non hanno realizzato i profitti necessari per compiere investimenti, e che pur avendo ottenuto una minore rigidità delle norme sul lavoro non hanno avuto a disposizione i capitali necessari per aumentare gli investimenti. Ma non è così: prima della crisi in Italia (come nel resto di Europa) si è registrato un forte incremento della quota dei profitti sul valore aggiunto (speculare alla caduta della quota del lavoro) che, in particolare dal 1993 al 2006, è aumentata di circa 11 punti. Allora, a partire da un’analisi ancora più approfondita sui limiti delle relazioni industriali negli ultimi decenni (vedi Acocella e Leoni, 2010) e sul comportamento miope della classe imprenditoriale italiana, si potrebbero trarre spunti interessanti sui quali costruire ed elaborare proposte ben più ambiziose per una riforma del lavoro volta seriamente ad accrescere l’occupazione, a migliorarne le condizioni, riconoscendo diritti e forme di lavoro stabili, capaci non solo di incontrare e soddisfare le esigenze dei lavoratori, ma anche quelle di imprese volte all’innovazione e alla valorizzazione del proprio capitale umano.
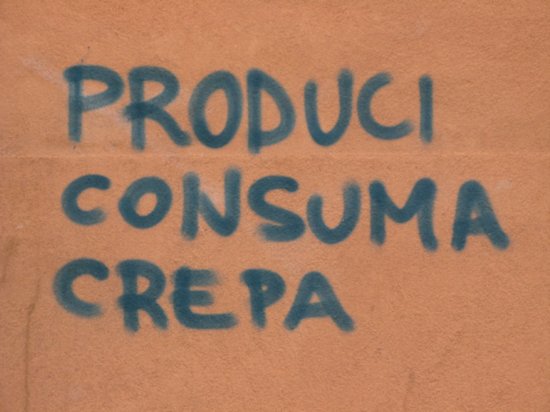 Il recente rapporto della Banca d’Italia sulle tendenze nel sistema produttivo del nostro paese e la manovra finanziaria con la quale la maggioranza di governo si accinge a scaricare i costi della crisi sui lavoratori mettono a dura prova il nocciolo della proposta social-liberale – la ‘terza via’ tra keynesismo e ultra-liberismo – secondo cui la crescita economica passerebbe attraverso l’eliminazione delle rigidità dell’offerta di lavoro, inserita tuttavia all’interno di una cornice regolatoria che non pregiudichi la coesione sociale (Bachet et al. 2001: 144). Più nello specifico, la selezione meritocratica, coniugata a comportamenti socialmente responsabili delle imprese volti a stimolare il ‘lavoratore ad una più alta qualità e partecipazione’ (Bellofiore 2004a) – innalzando così la produttività – eleverebbe la profittabilità aziendale. La ricchezza così creata verrebbe infine redistribuita ai lavoratori mediante l’intervento della politica economica[1].
Il recente rapporto della Banca d’Italia sulle tendenze nel sistema produttivo del nostro paese e la manovra finanziaria con la quale la maggioranza di governo si accinge a scaricare i costi della crisi sui lavoratori mettono a dura prova il nocciolo della proposta social-liberale – la ‘terza via’ tra keynesismo e ultra-liberismo – secondo cui la crescita economica passerebbe attraverso l’eliminazione delle rigidità dell’offerta di lavoro, inserita tuttavia all’interno di una cornice regolatoria che non pregiudichi la coesione sociale (Bachet et al. 2001: 144). Più nello specifico, la selezione meritocratica, coniugata a comportamenti socialmente responsabili delle imprese volti a stimolare il ‘lavoratore ad una più alta qualità e partecipazione’ (Bellofiore 2004a) – innalzando così la produttività – eleverebbe la profittabilità aziendale. La ricchezza così creata verrebbe infine redistribuita ai lavoratori mediante l’intervento della politica economica[1].